Caso Fiat: dagli aiuti di Stato alla convenienza speculativa (parte I)
La crisi finanziaria che grava sulle economie di tutte le nazioni – particolarmente quelle occidentali ed europee – aiuta a individuare con chiarezza l’obbiettivo finale delle forze attualmente dominanti: i cosiddetti “poteri forti”. L’eden del Mondialismo – un traguardo ormai quasi completamente raggiunto – è a questo punto palese e verificabile da tutti: moneta, grande industria e mezzi d’informazione in mano a un gruppo di banche supernazionali, di proprietà strettamente privata, che soggiogano le nazioni, espropriate ormai del tutto di ogni sovranità e inchiodate nello sterile ruolo – un vero e proprio supplizio di Sisifo – di inseguire un debito pubblico sempre più grande – conseguenza della natura clientelare e demagogica dei regimi democratici – e non risanabile, per l’impossibilità di controllare il denaro, la sua emissione, la sua gestione e il profitto da signoraggio.
Il grado di civiltà politica raggiunta, cioè la dura e difficoltosa conquista di una equa regolamentazione dei diritti e doveri tra i singoli cittadini e il potere – quello che in Italia si è chiamato “Stato sociale” – è ormai abbandonato a una fatale deriva.
cioè la dura e difficoltosa conquista di una equa regolamentazione dei diritti e doveri tra i singoli cittadini e il potere – quello che in Italia si è chiamato “Stato sociale” – è ormai abbandonato a una fatale deriva.
In tale scenario di progressivo arretramento si manifestano inoltre situazioni anomale e contraddittorie sulle quali è opportuno soffermarsi. Seguendo l’onda del libero mercato e della globalizzazione, si è provveduto a privatizzare tutto, togliendo allo Stato la possibilità di indirizzare lo sviluppo economico, garantire i servizi pubblici e dirigere le produzioni di interesse nazionale.
In questo quadro l’imponente costruzione dell’IRI è stata malamente liquidata. Ciò nonostante, quando subentrano difficoltà, da parte dei privati, si torna a chiedere allo Stato, senza ritegno alcuno, interventi e aiuti economici. Con una differenza sostanziale, rispetto al passato: oggi finanza e industria non accettano, in contropartita, alcun controllo, alcuna compartecipazione gestionale, e non offrono alcuna garanzia di utilizzare gli aiuti ricevuti esclusivamente all’interno della realtà economica nazionale.
È accaduto proprio questo, spudoratamente, per la crisi delle banche; continua ad accadere, ad ogni piè sospinto, in tutti i casi di difficoltà dei vari settori industriali.
Quando, nello scorso agosto, l’amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ha annunciato la decisione di trasferire parte della produzione auto da Mirafiori nei nuovi stabilimenti in Serbia, il clamore è stato grande. Da più parti si è sottolineato il fatto che l’azienda torinese, così facendo, arrecava un serio danno agli equilibri sociali ed economici, già instabili, dell’industria italiana. Ma, lapidaria e chiarificatrice, è giunta la dichiarazione del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: “In una libera economia e in un libero Stato, un gruppo industriale è libero di collocare dove è più conveniente la propria produzione”. E in effetti l’affermazione sembrerebbe apodittica, se non si tenesse conto del fatto che l’azienda in questione ha costruito le proprie fortune attraverso un secolo di aiuti di Stato e che, anche per l’avvenire, non mostra alcuna intenzione di rinunciare a questo tipo di sovvenzioni.
Gli aiuti di Stato all’industria privata sono infatti legittimi e importanti quando sono offerti all’interno dell’economia nazionale e a settori trasversali dove operano e producono, tra piccole, medie e grandi, migliaia di aziende nelle varie regioni. Differenti considerazioni vanno invece formulate quando i sussidi sono elargiti a una singola industria, come, ad esempio, in Italia è spesso accaduto per il settore automobilistico e la Fiat. In questo caso, infatti, occorre porsi delle domande precise:
se l’aiuto dello Stato, nelle sue varie forme – contributi a fondo perduto, finanziamenti per la ricerca, incentivi, rottamazioni, cassa integrazione, ecc. – nei decenni non ci fosse stato, quell’industria sarebbe riuscita, con le sue sole forze, ad ingrandirsi sino a sbaragliare tutta la concorrenza e rimanere l’unica del settore a livello nazionale?
- la ricchezza prodotta nei decenni da quell’azienda si è tutta riversata sull’economia nazionale o ha prodotto uno sproporzionato potere concentrato in una singola famiglia di capitalisti che, coerentemente allo spirito del libero mercato, ha spostato e continua a spostare nel mondo, a propria insindacabile discrezione, i suoi investimenti seguendo solo la bussola della convenienza speculativa?
- è compatibile questa situazione di privilegio – sganciato da vincoli nazionali – col fatto che gli aiuti ricevuti, essendo pubblici, provengono dalle tasche dei cittadini italiani?
Sarà istruttivo, dunque, per cercare risposte convincenti a queste domande, ripercorrere, almeno per sommi capi, la storia della Fiat, scegliendola come esempio estendibile a tutta la realtà industriale.
Nell’accingermi a sintetizzare questa storia, mi torna in mente un caro amico che incontrai, purtroppo solo per un breve periodo, all’inizio degli anni Ottanta: Gianni Mazzocchi.
Una parentesi su quell’incontro mi sembra degna di un certo interesse.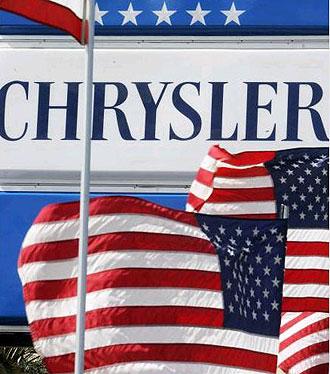 Si tratta di un personaggio di primissimo piano; uno dei più importanti editori del giornalismo italiano, che operò quando esisteva ancora qualche libertà di dar vita a giornali e arrivare nelle edicole senza dover subire, come oggi puntualmente avviene, il condizionante controllo di qualche gruppo bancario.
Si tratta di un personaggio di primissimo piano; uno dei più importanti editori del giornalismo italiano, che operò quando esisteva ancora qualche libertà di dar vita a giornali e arrivare nelle edicole senza dover subire, come oggi puntualmente avviene, il condizionante controllo di qualche gruppo bancario.
Nel 1929, a soli ventitré anni, fondò l’Editoriale Domus, rilevando l’omonima rivista creata l’anno precedente da Giò Ponti, ancor oggi la più importante vetrina italiana di architettura e arredamento.
Solo Domus non fu un’invenzione di Mazzocchi; tutte le testate che seguirono furono invece frutto della sua prorompente creatività: Panorama, L’Europeo – precursore di tutti i grandi rotocalchi del dopoguerra –, Settimo Giorno, Il Mondo. E divenne proverbiale il suo intuito nello scoprire “talenti”; fu il primo ad assumere Indro Montanelli quando era un giovane apprendista giornalista.
Amava immaginare e realizzare nuove iniziative, lanciarle sul mercato e portarle al successo. Negli anni Cinquanta, con i suoi giornali, Mazzocchi era in edicola con un milione di copie ogni settimana. Poi, raggiunti gli obbiettivi, perdeva l’entusiasmo, si distraeva con nuovi progetti e finiva per cedere le testate, vendendole senza speculazioni o addirittura, come per Il Mondo, regalandole.
Personaggio davvero sempre fuori dagli schemi. Angelo Rizzoli gli dette del “cretino”: “Tu fai bellissimi giornali e non ci guadagni. Io li faccio brutti e guarda cosa guadagno”. “Li faccio per divertirmi, e mi ci diverto” fu la risposta di Mazzocchi.
Alla fine troncò con i settimanali anche perché, raggiunti quei livelli di diffusione, c’era il rischio che divenissero inevitabili quelle connivenze politiche e finanziarie che lui vedeva come fumo negli occhi.
Fondò allora Quattroruote, che divenne subito il più importante e diffuso mensile di auto e motori d’Italia, e su questa iniziativa incentrò tutte le energie e gli entusiasmi. Supportato dal successo di questo mensile intraprese e vinse battaglie memorabili, tutte dedicate alla sicurezza sulle strade. Nel 1959 indusse il governo a ridurre il prezzo della benzina; spinse per la costruzione dell’Autostrada del Sole; ottenne l’abolizione della corsia centrale di sorpasso comune ai due sensi di marcia; si impegnò per far diventare obbligatorio il faro retronebbia rosso; riuscì a far vietare i cartelli pubblicitari lungo le autostrade, giudicandoli pericolosa causa di distrazione nella guida.
Gianni Mazzocchi nel 1983 ebbe l’occasione di leggere l’Uomo libero, rimase colpito e volle conoscerci. Dedicò una pagina intera per presentarci ai suoi lettori. “È uscita una rivista di eccezionale valore culturale” scrisse; e ancora: “Vorremmo che almeno i migliori e più colti lettori di Quattroruote potessero conoscerla”. E continuò con l’elenco degli articoli che sino allora avevamo pubblicato, tra i quali spiccavano quelli storico-revisionisti di Piero Sella, quelli incentrati sui valori e sul costume di Sergio Gozzoli e i miei, dedicati all’analisi politica.
Dopo tanti anni di esperienze giornalistiche e di vita, Mazzocchi era giunto a forti convinzioni critiche sul destino dell’Italia e dell’Europa. Si era reso conto del pesante prezzo che il nostro popolo era costretto a pagare per la scomparsa dei valori, per il perdurare nella mistificazione della storia e per la perdita della sovranità. Sentiva con chiarezza che c’era bisogno di una decisa sterzata e che i tempi erano maturi per lanciare alla pubblica opinione un discorso culturale e politico nuovo, e che ciò poteva essere fatto con noi de l’Uomo libero.
Una scelta che nell’Italia degli anni Ottanta appariva decisamente coraggiosa e controcorrente, tanto più se effettuata da un consolidato editore di successo. Mentre per noi rappresentava infatti il coerente approdo di antiche scelte e maturate analisi, per Mazzocchi le cose erano differenti. Poteva addirittura stupire una tal drastica svolta e una così forte presa di coscienza da parte di chi aveva sin lì dato voce, sui propri giornali, a firme come Enzo Biagi, Camilla Cederna, Diego Buzzati, Alberto Moravia, Arrigo Benedetti, Mario Pannunzio e Indro Montanelli, tutte lontane anni-luce dal nostro percorso politico e culturale e dal nostro mondo di valori.
Parlammo a lungo, su cosa fare e su come farlo, scendendo anche nel dettaglio dei particolari. Mazzocchi giunse addirittura a proporre, per sfruttare l’altissima tiratura di Quattroruote, di inserire in quella rivista un fascicolo in busta chiusa con scritto all’esterno che conteneva argomenti non concernenti auto o motori, ma che era destinato solo a un pubblico qualificato, libero e intelligente. “Così siamo sicuri che tutti lo leggeranno!”.
Noi avevamo già cominciato a scrivere e si stava predisponendo tutto per varare questa coraggiosa iniziativa, quando una brutta malattia si mise di traverso e bloccò tutto. Mazzocchi si aggravò velocemente e fu costretto a rinunciare ai suoi impegni. Ci lasciò il 24 ottobre 1984.
Si dissolse così la fattibilità di un progetto che certamente era ardito e controcorrente, ma cui oggi, osservando con occhio attento la storia degli anni Ottanta – un periodo di grandi cambiamenti; si pensi che proprio allora prese corpo la Lega di Umberto Bossi –, possiamo tranquillamente attribuire ampie potenzialità di successo.
Chiusa questa parentesi “fuori tema”, torniamo all’oggetto della nostra trattazione.
Fu proprio durante gli incontri con Gianni Mazzocchi, nella sua casa al mare di Gabicce, nelle sue Marche, e nella sua villa di Gignese sul Lago Maggiore che, grazie ai suoi racconti densi di esperienze dirette e competenza, imparai a conoscere a fondo e nella giusta luce fenomeni industriali come la Fiat e a valutare quanto fosse stata determinante, per i loro successi, la benevola, favorevole e talvolta persino “complice” mano protettrice dello Stato.
Alla fine dell’Ottocento la comparsa del motore a scoppio applicato nella costruzione di veicoli affascinò molti e furono numerose le aziende che presero le mosse per fabbricare questi nuovi mezzi di trasporto. L’11 luglio del 1899 un gruppo di imprenditori fondò la Fabbrica Italiana Automobili Torino con un capitale di 800.000 lire diviso in 4.000 azioni. I padri fondatori furono tre nobili (il conte Roberto Biscaretti, il conte Emanuele Cacherano e il marchese Alfonso Ferrero), due avvocati (Carlo Racca e Cesare Goria Gatti), un piccolo imprenditore (Michele Lanza, produttore di candele di cera), il possidente Lodovico Scarfiotti, il banchiere Michele Ceirana-Mayneri e l’agente di cambio Luigi Damevino.
L’idea iniziale era stata del conte Cacherano e dell’avvocato Goria Gatti, grandi appassionati di automobili, che furono anche i promotori dell’ACI, l’Automobile Club d’Italia.
Alla società doveva partecipare anche Giovanni Battista Ceirano che – per la sua esperienza di produzione artigianale di autovetture – era considerato il migliore esperto meccanico sulla piazza. Ma – si disse per questioni di rango – Ceirano fu escluso e Michele Lanza, ritenendo ciò un grave errore, il 10 luglio, il giorno precedente la firma dell’atto costitutivo, si ritirò dall’affare. La sua quota azionaria fu spartita, in fretta e furia, tra il Banco di Sconto e Sete e un possidente di Villar Perosa, il trentatreenne Giovanni Agnelli.
Ma Giovanni Battista Ceirano e la sua competenza, questioni di rango a parte, effettivamente rappresentavano un ghiotto boccone per chi volesse costruire automobili nella Torino di quel fine secolo. Ed erano considerati preziosi anche le maestranze, già valide e selezionate – uno dei giovani meccanici di questa azienda si chiamava Vincenzo Lancia – e i progetti già collaudati dell’Accomandita Ceirano e C. Da quell’azienda era già stato messo sul mercato un nuovo modello di automobile, la Welleyes che, nonostante il nome straniero – scelto perché richiamava quello di una bicicletta di successo – era tutta italiana, anzi torinese.
La prima delibera del Consiglio d’Amministrazione della neonata Fiat riguardò proprio l’acquisto della Ceirano. Cacherano e Goria Gatti erano riusciti ad avere in mano le garanzie di quella fabbrica, rilasciate per ottenere finanziamenti, e fu così facile acquistare tutto – attrezzature, disegni, brevetti e maestranze specializzate – per sole 30.000 lire, meno del prezzo di vendita di due autovetture. A Giovanni Battista Ceirano, obtorto collo, non rimase che accettare l’assunzione, come agente di vendita, nella nuova azienda.
La prima auto messa in produzione dalla Fiat fu la 31/2 HP, copia identica della Welleyes.
I sistemi “disinvolti” usati dalla Fiat per acquisire tecnologia, progetti, mercati e maestranze fagocitando la concorrenza non furono utilizzati solo nel caso Ceirano, ma anche in molte altre occasioni nel corso dei decenni.
Nella stessa riunione costitutiva del Consiglio d’amministrazione fu eletto presidente Scarfiotti e segretario, come consuetudine, il più giovane, Giovanni Agnelli, che da quella carica iniziò la fulminea carriera che lo condusse a divenire – nonostante le inizialmente poche azioni in suo possesso – prima “membro delegato del Consiglio” e poi Amministratore delegato.
Agnelli indubbiamente fu un grande organizzatore e un abilissimo manipolatore di giochi finanziari, ma ciò che più lo aiutò nel perseguire i successi che conosciamo, fu la sua capacità di ottenere commesse di Stato – militari e civili – intrattenendo ottime relazioni col potere: monarchia, governo, amministrazioni locali. Grazie a ciò, oltre alle forniture – che già lo ponevano su un piano privilegiato rispetto alla concorrenza – iniziò la serie doviziosa e infinita delle sovvenzioni pubbliche.
Come sempre, agli uomini di successo, oltre alle qualità professionali e allo spirito imprenditoriale non deve far difetto la fortuna. E ciò è confermato anche dalle vicende legate agli inizi della Fiat.
Si narra che la monarchia in Italia frenasse sugli investimenti da parte dello Stato nel settore automobilistico. Vittorio Emanuele – mostrando grande “lungimiranza” – considerava i nuovi mezzi di trasporto “macchine pericolose ed abominevoli”. Questo fino al 1904, anno in cui un guasto ferroviario bloccò Sua Maestà alle porte di Roma. Il principe Colonna giunse prontamente con la sua nuova Fiat a soccorrere il sovrano e condurlo al Quirinale. Vittorio Emanuele rimase talmente ben impressionato che non solo ribaltò il suo giudizio sulle automobili, ma dette istruzioni affinché alla Fiat fosse immediatamente concesso il titolo di “Fornitore della Real Casa”. Il re, nel luglio del 1905, volle recarsi personalmente a visitare, a Torino, gli stabilimenti di via Dante.
Ma la scalata di Agnelli non fu solo una sequela di facili successi.
Per fare il grande balzo verso un vero e proprio livello industriale, operò attraverso giochi finanziari e finanziamenti, a dir poco, arditi. Primo passo fu – quando si era raggiunta la produzione di cinquanta auto al mese – la riduzione ad un ottavo del valore nominale delle azioni, allargando così a dismisura il numero degli investitori e contemporaneamente espropriando il gruppo dei fondatori, eccezion fatta per i registi dell’operazione: Agnelli, Scarfiotti e Damevino. Successivamente, con la complicità della Banca Commerciale – del banchiere ebreo polacco Giuseppe Toeplitz – vengono annunciati enormi utili, pagati favolosi dividendi, allargato ulteriormente il numero degli azionisti. Alla fine di questo bailamme i tre “registi”, raggiunto il possesso della maggioranza delle azioni, liquidarono la vecchia società e fondarono una nuova Fiat ricostituita con un capitale elevato a nove milioni, divisi in 90.000 azioni.
Nel frattempo – marzo 1905 – grazie ancora una volta ai buoni uffici della Comit, l’industria di Agnelli rilevò le Officine Meccaniche Ansaldi, pagando un milione di lire una realtà produttiva che al momento dell’acquisto disponeva di ordinativi sufficienti a garantire alla Fiat un utile a breve di 2.450.000 lire.
I risultati di questa operazione – i cui “poco ortodossi” retroscena vennero successivamente alla luce – e la voce, rivelatasi poi infondata, che l’intera Fiat stava per essere venduta per 50 milioni a un gruppo di banchieri inglesi, fecero schizzare il valore delle azioni. Dalle 100 lire dell’anno precedente, nel giugno 1906 aveva raggiunto la quota di 1.885 lire. Nei momenti di massima euforia si ebbero dei picchi addirittura di 2.450 lire.
Ma si trattava di un denso fumo, molto ben diffuso, che però, quando cominciò a diradarsi, lasciò intravedere un arrosto di dimensioni assai modeste. A questo punto la discesa del titolo fu ancora più veloce di quanto lo era stato il suo crescere. All’inizio del 1907 era precipitato a 65 lire; nell’autunno sprofondò a quota 17 lire, otto lire in meno del valore nominale.
Era il crack. A salvare Agnelli e la Fiat, grazie alle altolocate relazioni e alle aspettative di ghiotte commesse militari – già erano state affidate a quell’industria torinese la fabbricazione di autocarri e sottomarini –, intervenne ancora una volta Toeplitz con la sua Comit che, con l’appoggio di tre banche minori – Ceriana, Grasso e Marsaglia – reintegrò il capitale della società in difficoltà.
Mentre la pattuglia dei disinvolti imprenditori Fiat viene salvata, un numero altissimo di risparmiatori e di piccole e medie aziende – molte proprio nel mondo automobilistico – che si trovavano in possesso di quelle azioni, vanno in rovina. A questo punto, in parecchi si fecero avanti per vederci chiaro. La Stampa, ancora non di proprietà della famiglia Agnelli, richiese insistentemente l’intervento della magistratura. Erano già ricorsi al Tribunale, contro la nuova Fiat, i soci fondatori del 1899 tenuti fuori dagli sviluppi successivi, mentre il Banco di Liguria, che deteneva una decina di titoli, aveva impugnato l’atto di liquidazione della vecchia società.
Il 23 giugno 1908 Agnelli, Scarfiotti e Damevino furono denunciati per truffa, “illecita coalizione, aggiotaggio in borsa e falso nei bilanci sociali”. La Questura, nel suo rapporto, accusava gli imputati di aver “provocato nel 1905-1906 enormi e ingiustificati rialzi nelle azioni della Fiat, sia col suddividere le primitive azioni, sia col porre nel marzo 1906 in liquidazione la Fiat per ricostituirla immediatamente dopo con un moltiplicato numero di azioni, sia con l’assorbimento ingiustificato dello stabilimento Ansaldi”. Un altro espediente illecito – proseguiva il rapporto – era stato quello di “avere dichiarato nel bilancio 31 dicembre 1906 utili non realmente conseguiti, che si erano poi divisi nel 1907, epoca nella quale la società già si trovava in condizioni critiche”. Si accusarono inoltre i tre soci di aver diffuso – per far lievitare il valore delle azioni – anche notizie, poi rivelatesi completamente infondate, riguardanti enormi commesse dall’America.
Fu grande scandalo, ma non vi fu alcun arresto.
Il 23 agosto il giudice istruttore rinviò gli indagati a giudizio. Un poderoso collegio di difesa fu subito messo in campo per ottenere proroghe e spostare il dibattimento a tempi nei quali il clamore dello scandalo fosse scemato. Contemporaneamente, pesanti pressioni giunsero sulla Procura. Il ministro della Giustizia, Vittorio Emanuele Orlando, fece sapere che una sentenza di condanna avrebbe potuto “influire in modo sinistro sulla sorte di industrie locali, che sono pure notevoli elementi dell’industria nazionale”. Una ben orchestrata campagna di informazione sulla stampa esaltò, nello scenario della guerra in Libia, il ruolo ricoperto dagli autocarri Fiat 15 bis impiegati nelle operazioni belliche.
Il 22 maggio 1912 il Tribunale giunge a sentenza mandando tutti assolti. Il processo d’appello si aprì il 14 aprile 1913. C’era aria di guerra e di imponenti commesse militari per la Fiat. Arrivò a Torino, per presiedere il collegio di difesa, Vittorio Emanuele Orlando in persona. La conferma dell’assoluzione – una semplice formalità – cadde nel disinteresse più generale.
di: Mario Consoli a.sassone@rinascita.eu
Fiat: a guerra finita il bottino è internazionale (parte II)
Giovanni Agnelli era divenuto praticamente il consulente del governo per gli armamenti e i trasporti
Agnelli a questo punto “si prepara alla guerra” organizzando la propria catena produttiva e soprattutto assicurandosi che le commesse militari fossero cospicue, vantaggiose e che arrivassero alla Fiat e non alla concorrenza. Grande referente in questa operazione fu il piemontese Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio negli anni cruciali della guerra di Libia e dell’adeguamento dell’esercito alle nuove tecnologie di trasporto. Con il successore, Antonio Salandra, le cose continuarono ad andare a gonfie vele.
Al maggio del 1915 gli stabilimenti di Agnelli avevano già fornito alle Forze Armate più di 1.600 autoveicoli e stavano lavorando ai 18P, destinati al trasporto delle munizioni, alla produzione di mitragliatrici e di proiettili. Alla concorrenza erano andate le briciole: 298 autoveicoli erano stati ordinati all’Isotta-Fraschini, 195 alla Spa, 120 all’Itala, 110 alla Züst. Giovanni Agnelli era divenuto praticamente il consulente del governo per gli armamenti e i trasporti. Dante Ferraris, vice-presidente della Fiat, era stato nominato capo del Comitato regionale di mobilitazione industriale, incaricato della ripartizione delle forniture. Il figlio di Agnelli, Edoardo, era stato inviato a Udine come vice direttore del parco automobilistico militare, alle dipendenze di un capitano che, nella vita civile, dirigeva la concessionaria Fiat di Milano. Il giornalista Ugo Ojetti arrivò a scrivere: “Agnelli è quasi il padrone”.
A questo punto l’Amministratore delegato della Fiat allarga il tiro agli eserciti alleati. Con quello russo firma un accordo per la fornitura di 6.000 autocarri con i relativi pezzi di ricambio per un importo di 240 milioni. Altre forniture vengono inviate in Francia. Neanche la rivoluzione di Ottobre e l’uscita della Russia dalla guerra bloccano gli affari di Agnelli che riesce a farsi pagare dai Soviet – con l’intercessione del sindacalista Bruno Buozzi e del direttore dell’Avanti, Giacinto Menotti Serrati – le forniture già effettuate al comando zarista e vende a Francia e Inghilterra la produzione ancora non consegnata, con un aumento del 20% dei prezzi precedentemente concordati coi russi.
Neanche la rivoluzione di Ottobre e l’uscita della Russia dalla guerra bloccano gli affari di Agnelli che riesce a farsi pagare dai Soviet – con l’intercessione del sindacalista Bruno Buozzi e del direttore dell’Avanti, Giacinto Menotti Serrati – le forniture già effettuate al comando zarista e vende a Francia e Inghilterra la produzione ancora non consegnata, con un aumento del 20% dei prezzi precedentemente concordati coi russi.
Strada facendo la Fiat continuava ad assorbire pezzi di una concorrenza sempre più in difficoltà. Nel dicembre 1917 sono assorbite, grazie a un consorzio di garanzia diretto dalla solita Comit, anche le Ferriere Piemontesi, le Officine Diatto e le Industrie Metallurgiche di Torino. Si tratta di acquisizioni fondamentali, perché tutte aziende produttrici di materie prime necessarie alla Fiat, come acciai speciali, materiale ferroviario ed energia elettrica.
A guerra finita il bottino poi si fa internazionale: Agnelli riesce addirittura ad ottenere dei rappresentanti nella delegazione economica italiana al tavolo della pace, a Versailles. È così che alla Fiat furono assegnati:
- il pacchetto di maggioranza dell’Alpine Montangesellschaft di Vienna, proprietaria delle miniere di ferro della Stiria e di numerose fonderie e imprese metalmeccaniche;
- la partecipazione – assieme alla Terni, l’Ilva e l’Ansaldo – alla Società Commerciale d’Oriente per lo sfruttamento dei giacimenti carboniferi di Eraclea nell’Anatolia turca;
- le partecipazioni agli stabilimenti siderurgici di Servola, a Trieste.
I tre anni della guerra erano stati sufficienti ad imprimere alla storia della Fiat un’impennata senza eguali. Da 4.000 a 40.000 dipendenti. Un capitale che, tra titoli e partecipazioni, da 7 milioni del 1915 nel 1918 era lievitato a quasi 100 milioni. Cifra più vicina ai numeri delle leggi finanziarie dello Stato che a quelli dei bilanci delle industrie private.
Peraltro la concentrazione delle forniture militari in una sola azienda – 92% degli autocarri e 80% dei motori di aviazione – avevano anche causato gravi contrattempi nell’andamento delle strategie di guerra. Essendo state disincentivate le altre industrie a un incremento delle potenzialità produttive, quando si fu alla vigilia dell’attacco di Vittorio Veneto e le esigenze di rimpiazzare le perdite di autocarri subite nel corso delle battaglie – in particolar modo nella ritirata di Caporetto – divenne impellente, la sola Fiat non fu in grado di rispondere con la tempistica richiesta, causando intoppi più che preoccupanti.
Il 25 settembre 1918 lo Stato Maggiore segnala il problema. Il 12 ottobre il generale Pietro Badoglio invia un messaggio al presidente del Consiglio – Vittorio Emanuele Orlando, il grande difensore di Agnelli e della Fiat – per denunciare l’impossibilità di effettuare il “completamento dei piani di operazione militare” per colpa della mancata attuazione del programma di produzione di automezzi concordato con la Fiat quattro mesi prima.
Nonostante ciò, lo Stato continuò a concentrare le proprie commesse, a favorire l’elefantiasi di quell’industria torinese e a rimpinzare le tasche di Giovanni Agnelli. Riferisce lo storico Valerio Castronovo: “Agnelli non aveva più bisogno di intermediari per trovare udienza presso Orlando o presso Nitti per la sistemazione dei contratti stipulati con l’amministrazione militare o per la distribuzione delle “spoglie di guerra”. La Fiat riuscì infatti ad assicurarsi ampie possibilità di lavoro per i mesi successivi la fine delle ostilità. Ancora nel 1919 il governo continuò ad acquistare numerosi autoveicoli per provvedere alle necessità di trasporti delle regioni annesse. Il ministero degli Esteri si preoccupò inoltre di sollecitare accordi specifici con la Romania, la Polonia e il Belgio al fine di agevolare il collocamento della produzione automobilistica. E per altri automezzi Fiat si studiò un programma di incremento dei servizi pubblici. Agnelli ottenne, infine, un trattamento favorevole anche nella liquidazione delle commesse in lavorazione. Con un decreto del 19 giugno 1919 venne concesso alla Fiat e alla consociata SIA un indennizzo di 40 milioni per “mancato ammortamento di impianti e di attrezzi e per svalutazioni di materie prime”. Non solo; l’amministrazione militare si assunse il carico del ritiro delle parti lavorate di materiale bellico esistenti presso le officine di corso Dante al prezzo di oltre 32 milioni e la successiva retrocessione alla Fiat di tali materiali al prezzo di 7 milioni. Venne concesso, inoltre, il rimborso delle tasse di registro già pagate su forniture complete o frazioni di forniture annullate, mentre altre clausole accordarono alla società torinese il rimborso integrale delle penalità su forniture di materiale d’aviazione. Circa 65 milioni erano stati così elargiti alla Fiat”.
Tanta dovizia di aiuti, e quindi di liquidità, contribuirono ad aumentare la sfera d’influenza di Agnelli in ampi settori della realtà industriale nazionale: Dalmine, Magneti Marelli, Società Elettricità Alta Italia, Società Forze Idrauliche del Moncenisio, Società Idroelettrica Piemonte, Rumianca, Unione Italiana Cementi, Rinascente, Società Assicuratrice Industriale. E, assieme al finanziere Riccardo Gualino, la Fiat si assicurò un posto nel Consiglio d’amministrazione del Credito Italiano. Negli anni del dopoguerra per la Fiat continuano i “buoni affari”. Giolitti, prima di dimettersi, inasprisce la stretta doganale per ciò che riguarda auto e cuscinetti a sfere; un’automobile straniera viene così a costare il doppio di una italiana. E Agnelli, nel gestire i propri interessi, come ha già fatto in passato e farà in futuro, manifesta una spregiudicatezza ai limiti della liceità: all’insaputa del governo, vende una società siderurgica austriaca ottenuta dall’Italia al tavolo della Conferenza di pace. Si aprono delicate questioni politico-diplomatiche e il ministro Ivanoe Bonomi, visibilmente irritato, definisce “deplorevole” il comportamento dell’industriale torinese. Durante i moti politici e sindacali che seguirono la fine della guerra e sfociarono nell’occupazione delle fabbriche, Agnelli, seguendo di volta in volta ciò che gli appariva la convenienza del momento e confidando in un risolutore intervento politico di Giolitti, si distinse in una serie di iniziative personalistiche e contraddittorie che andarono a provocare ora gli attacchi dei sindacati, ora quelli degli altri imprenditori. La goccia che fece traboccare il vaso fu la promessa, poi ovviamente rimangiata, fatta ai sindacati di trasformare la Fiat in una cooperativa, grazie alla quale ottenne lo sgombero dell’occupazione degli stabilimenti. Il presidente della Lega Industriale, ingegner Mazzini, bollò questa iniziativa come “atto più che di indisciplina, di vera aberrazione”. La situazione divenne così tesa che Agnelli arrivò a minacciare le dimissioni. L’unico imprenditore a schierarsi, in quel momento, dalla sua parte fu il massone Vittorio Valletta che, nominato prontamente Direttore amministrativo della Fiat, seguì da allora al 1966 le vicende dell’azienda torinese in ruoli dirigenziali. Superata l’enpasse del momento, Agnelli ripartì con la sua opera di industriale e di finanziere. Ma con qualche difficoltà in più. Al governo ora c’era Mussolini e non più i suoi benevoli referenti Giolitti, Orlando e Nitti..
Negli anni del dopoguerra per la Fiat continuano i “buoni affari”. Giolitti, prima di dimettersi, inasprisce la stretta doganale per ciò che riguarda auto e cuscinetti a sfere; un’automobile straniera viene così a costare il doppio di una italiana. E Agnelli, nel gestire i propri interessi, come ha già fatto in passato e farà in futuro, manifesta una spregiudicatezza ai limiti della liceità: all’insaputa del governo, vende una società siderurgica austriaca ottenuta dall’Italia al tavolo della Conferenza di pace. Si aprono delicate questioni politico-diplomatiche e il ministro Ivanoe Bonomi, visibilmente irritato, definisce “deplorevole” il comportamento dell’industriale torinese. Durante i moti politici e sindacali che seguirono la fine della guerra e sfociarono nell’occupazione delle fabbriche, Agnelli, seguendo di volta in volta ciò che gli appariva la convenienza del momento e confidando in un risolutore intervento politico di Giolitti, si distinse in una serie di iniziative personalistiche e contraddittorie che andarono a provocare ora gli attacchi dei sindacati, ora quelli degli altri imprenditori. La goccia che fece traboccare il vaso fu la promessa, poi ovviamente rimangiata, fatta ai sindacati di trasformare la Fiat in una cooperativa, grazie alla quale ottenne lo sgombero dell’occupazione degli stabilimenti. Il presidente della Lega Industriale, ingegner Mazzini, bollò questa iniziativa come “atto più che di indisciplina, di vera aberrazione”. La situazione divenne così tesa che Agnelli arrivò a minacciare le dimissioni. L’unico imprenditore a schierarsi, in quel momento, dalla sua parte fu il massone Vittorio Valletta che, nominato prontamente Direttore amministrativo della Fiat, seguì da allora al 1966 le vicende dell’azienda torinese in ruoli dirigenziali. Superata l’enpasse del momento, Agnelli ripartì con la sua opera di industriale e di finanziere. Ma con qualche difficoltà in più. Al governo ora c’era Mussolini e non più i suoi benevoli referenti Giolitti, Orlando e Nitti..
di Mario Consoli
Fiat: da Giolitti, Orlando e Nitti a Mussolini (parte III)
Col fascismo si instaurò dunque un clima da “pace armata”. Il Regime si guardò bene dal chiudere tutti i rubinetti, dall’altra evitò di contribuire, a spese dello Stato, ad un ulteriore ampliamento di una potenza economica
Col fascismo i rapporti furono problematici fin dall’inizio. L’avvocato Cesare Maria De Vecchi, futuro quadrumviro della Marcia su Roma, nel 1920, messosi dalla parte di alcuni operai licenziati dalla Fiat, fu l’organizzatore di una manifestazione di protesta sotto le finestre di casa Agnelli.
Nel marzo del 1923 Mussolini ritenne di poter imbrigliare il presidente dell’azienda torinese, nominandolo senatore del Regno, anche per assecondare i molti protettori che pur sempre continuava ad avere. Agnelli gradì il titolo, si presentò alla cerimonia di attribuzione del seggio, ma non partecipò mai ai lavori del Senato. Preferì tornare a Torino e ai suoi affari. Evidentemente, lo Stato doveva essere funzionale ai suoi interessi e non viceversa.
È questo un concetto che ha sempre ispirato quel personaggio. In un colloquio con Valletta del febbraio 1933 il presidente della Fiat afferma di essere contrario all’acquisto di azioni dell’IRI “perché le obbligazioni sono per aiutare gli industriali. Noi dovremmo esser piuttosto dall’altra parte: finché fosse farsi imprestar soldi dal governo bene, ma noi prestarne al governo è un po’ troppo!”. Cinquant’anni dopo, il nipote Gianni, in un’intervista, ripeté il concetto: “Quando facciamo qualcosa con lo Stato, è nel contesto di un’associazione che funziona secondo i principi del settore privato. Non viceversa”.
Col fascismo si instaurò dunque un clima da “pace armata”. Da una parte il Regime si guardò bene dal chiudere tutti i rubinetti a una realtà industriale che controllava decine di migliaia di posti di lavoro ed aveva ormai assunto una dimensione tecnologica di primaria importanza e raggiunto mercati internazionali. Dall’altra evitò di contribuire, a spese dello Stato, ad un ulteriore ampliamento di una potenza economica che considerava già troppo ingombrante.  La concorrenza, forse per la prima volta, riuscì a respirare e portare avanti qualche progetto autonomo. Quando cadde il Regime fascista in Italia, oltre alla Fiat, operavano più di dieci fabbriche di automobili: Lancia – la prima in Europa a dotare di impianto elettrico le autovetture e disporre le valvole a V –, Isotta Fraschini, Maserati, Cemsa, Diatto, Bianchi, Ghia, Moretti, Bernardi, Siata, per non parlare dell’Alfa Romeo le cui auto nel Ventennio, con grande stizza di Agnelli, erano divenute un simbolo; sono “rapide come il mio pensiero” aveva detto Mussolini, e sostituì la Fiat a disposizione della presidenza del Consiglio con un’Alfa. I gerarchi seguirono l’esempio; Italo Balbo addirittura le collezionò. A ferire profondamente l’orgoglio del “senatore” giunse poi la dichiarazione di Henry Ford: “Quando vedo passare un’Alfa Romeo mi levo il cappello”.
La concorrenza, forse per la prima volta, riuscì a respirare e portare avanti qualche progetto autonomo. Quando cadde il Regime fascista in Italia, oltre alla Fiat, operavano più di dieci fabbriche di automobili: Lancia – la prima in Europa a dotare di impianto elettrico le autovetture e disporre le valvole a V –, Isotta Fraschini, Maserati, Cemsa, Diatto, Bianchi, Ghia, Moretti, Bernardi, Siata, per non parlare dell’Alfa Romeo le cui auto nel Ventennio, con grande stizza di Agnelli, erano divenute un simbolo; sono “rapide come il mio pensiero” aveva detto Mussolini, e sostituì la Fiat a disposizione della presidenza del Consiglio con un’Alfa. I gerarchi seguirono l’esempio; Italo Balbo addirittura le collezionò. A ferire profondamente l’orgoglio del “senatore” giunse poi la dichiarazione di Henry Ford: “Quando vedo passare un’Alfa Romeo mi levo il cappello”.
Anche le ricattatorie domande di fondi che giungevano a Roma da Torino trovavano un’accoglienza ben diversa da quella cui i precedenti governi avevano abituato Agnelli. A seguito di un’ennesima richiesta di interventi, inoltrata tramite la prefettura del capoluogo piemontese alla presidenza del Consiglio dei ministri, il 5 luglio 1927 Mussolini scrisse al prefetto di Torino una lettera estremamente chiara: “Ad evitare il grave e assurdo pericolo che la Fiat finisca per considerarsi un’istituzione intangibile e sacra dello Stato, al pari della Dinastia, della Chiesa, del Regime e avanzi continue pretese, bisogna considerare la Fiat come una intrapresa privata simile a migliaia di altre, del destino delle quali lo Stato può anche disinteressarsi. La Fiat ha molti operai, sta bene, ma questo non le dà un titolo a speciali privilegi. Il numero degli operai passibili di licenziamento può essere un elemento di considerazione benevola nel caso che la Fiat sia in linea col Regime; altrimenti i progettati licenziamenti hanno l’aria di un ricatto che il governo fascista non subirà mai, anche se la Fiat chiudesse – domani – tutte le sue officine. Io credo che un atteggiamento di perfetta indifferenza, di fronte alla condotta e alle vicende della Fiat sia quella da seguire. Il problema della disoccupazione sarà affrontato dal Regime con i suoi mezzi al momento opportuno. La Fiat faccia il suo gioco. Il Regime fa il suo. Questa specie di ossessione a fondo ricattatorio, su quello che fa o non fa, farà o non farà, l’impresa privata della Fiat deve finire…”.
E l’insofferenza per l’esosità di Agnelli circolava a tutti i livelli del Regime. Riportiamo un simpatico aneddoto che ne rende bene l’idea. Giuseppe Bottai, nel suo diario, elencando i partecipanti ad un ricevimento a casa Ciano, scrive: “Di passaggio Suni [diminutivo di Susanna] che va a Roma in terza classe per economia: è infatti la nipote di Agnelli. Commenta Galeazzo: “Neppure viaggiando, il nonno vuole restituire allo Stato i denari che gli ruba con le forniture”.
Il fascismo indubbiamente fece da freno, ma ottenne il risultato di rallentare la corsa della Fiat ad uno status di sempre maggiore privilegio, non certo quello di bloccarla. Ricorda ancora Bottai: “Un giorno annunciano che c’è in anticamera Giovanni Agnelli. Entra, mi saluta, si siede. Comincia a parlarmi, si alza, passeggia, mi dice “giovanotto”, parla per cinque minuti. Non sapevo più se il ministro ero io o lui”.
Nel 1927 Agnelli, sfruttando la rivalutazione della lira, la famosa “quota 90” – che peraltro aveva fortemente contrastata – ottenne nuove facilitazioni fiscali. Nello stesso anno fondò l’IFI, l’Istituto finanziario funzionale al controllo dei titoli Fiat e dei finanziamenti delle consociate e ampliò i suoi interessi in Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia, Trentino e Toscana.
Dopo l’istituzione dell’IRI, Mussolini voleva evitare che il risanamento finanziario e produttivo italiano potesse diventare occasione per ulteriori vantaggi per la grande industria privata. In una nota spedita nel 1934 dalla Rocca delle Caminate al ministro delle Finanze, il Duce dispose: “Nessuna vendita agli Agnelli da parte dell’IRI di azioni EDISON o ILVA. È mia convinzione che invece di gonfiare, sarebbe meglio deflazionare il complesso Agnelli, che va dalle auto ai cantieri, dal giornalismo agli alberghi di montagna”.
Anche precedentemente Mussolini si era messo di traverso nella trattativa tra l’IRI e una cordata guidata dal “senatore” torinese per l’acquisizione delle società telefoniche. L’affare andò in fumo e fu costituita, all’interno dell’Istituto, una società finanziaria telefonica, la STET.
Nonostante queste martinicche, nel 1938 arrivano agevolazioni doganali, viene impedita alla Ford l’apertura di una sua sede a Trieste, per “questioni di ordine nazionale”, e negata l’autorizzazione alla costruzione di uno stabilimento a Livorno, nonostante l’azienda americana avesse già acquistato il terreno necessario. Inoltre, dopo le difficoltà provocate dalla crisi del 1930, che aveva contratto i mercati e, conseguentemente, ridotto produzioni e posti di lavoro, il governo italiano si fece garante delle esportazioni in URSS sino al 75% del valore complessivo di ogni fornitura, aprendo alla Fiat un nuovo importante mercato. Per “ringraziamento” la Fiat, tenendone all’oscuro le autorità italiane e lo stesso Mussolini, acquisisce a Mosca una ulteriore ricca commessa: la costruzione di una grossa fonderia di leghe leggere destinate alla produzione di motori d’aviazione. Il rappresentante di Agnelli, Ugo Gommato, si fa, per l’occasione, fotografare a fianco dei “commissari del popolo” e del fuoruscito Palmiro Togliatti.
di Mario Consoli
FIAT: dalla nascita di Mirafiori al boom economico degli anni `60 (PARTE IV)
Nel dopoguerra Giovanni Agnelli e Vittorio Valletta per ricrearsi una “verginità” politica, collaborarono col Comitato di Liberazione e finanziarono la lotta partigiana
Negli anni Trenta, soprattutto con la guerra d’Etiopia, riprendono respiro le commesse militari, che però furono assai criticate perché la Fiat, invece di produrre veicoli adatti ai territori africani e alle particolari esigenze belliche del momento, si era limitata ad assemblare pezzi di veicoli civili già esistenti: autotelaio del tipo 508 Balilla inserito in camioncini della portata di 400 kg e autovetture civili di grossa cilindrata camuffati con una mise coloniale. Nonostante le sanzioni economiche varate dalla Società delle Nazioni, le truppe italiane furono costrette ad arrivare ad Adula, Azuma e Malvale più su automezzi Ford che Fiat. L’azienda americana fornì per l’occasione 3.000 camion.
Solo successivamente da Torino cominciarono ad arrivare autoveicoli di tipo nuovo, con l’applicazione di tecnologie più avanzate e mirate alle esigenze militari. Analoghi deludenti risultati si ebbero per gli armamenti: le cinquemila mitragliatrici ordinate alla Fiat arrivarono in ritardo e di una qualità inadatta all’impiego richiesto; il raffreddamento ad acqua di cui erano dotate, di superata concezione, si dimostrò infatti particolarmente problematico in terra d’Africa, dove l’acqua notoriamente scarseggia. Ciò nonostante, gli affari continuarono a portare ad Agnelli utili ragguardevoli.
Lo stabilimento del Lingotto si era fatto troppo stretto per le produzioni previste e, dopo il 1934, nasceva il progetto di una nuova megastruttura industriale finanziata proprio dagli utili ottenuti con la guerra di Etiopia: più di 600 milioni di lire.  Fu scelta un’area di oltre un milione di metri quadrati, dove era sorta in passato la scuderia di Guarino, sulla strada di Stupinigi, località nota per il casino di caccia dei Savoia, nel territorio a sud di Torino. Nasceva la Fiat Mirafiori.
Fu scelta un’area di oltre un milione di metri quadrati, dove era sorta in passato la scuderia di Guarino, sulla strada di Stupinigi, località nota per il casino di caccia dei Savoia, nel territorio a sud di Torino. Nasceva la Fiat Mirafiori.
Nuovo contrasto col fascismo. Mussolini, visto il progetto, manifestò tutta la propria contrarietà. Avrebbe preferito uno stabilimento decentrato, dove già esisteva manodopera disponibile – per evidenti questioni di ordine sociale – evitando inoltre concentramenti industriali pericolosi per motivi militari. Agnelli dimostrando ancora una volta di essere un forte uomo di potere e che il Fascismo non fu una ferrea dittatura – non sentì ragioni e dette inizio ai lavori, chiamando a Torino oltre 5.000 lavoratori, che reclutò nel Veneto e in Sicilia. Come “contentino” al Regime, promise di costruire una piccola fabbrica sotterranea per la produzione d’aerei nei dintorni di Firenze e di ampliare il centro di distribuzione di Ancona. Nel 1937, grazie al successo dei modelli Topolino e 1100, la Fiat arriva al ritmo produttivo annuo di 66.000 autoveicoli. Anche la guerra di Spagna fu occasione di grandi utili; le importanti commesse di camion e aerei per i franchisti furono finanziariamente coperte dal governo italiano. Inoltre Giovanni Agnelli aveva ritenuto opportuno, per l’occasione, rinfrescare lo status di senatore, ottenendo così di far parte di due strategiche Commissioni parlamentari: quella per la legislazione doganale e gli scambi commerciali e quella per gli affari esteri.
Nel frattempo l’IFI era arrivato a controllare parecchie decine di aziende operanti nei più diversi settori produttivi, tra cui l’Unione Cementi Marchino, Ferrania, Italedile, Cinzano, Manifattura Pellami e Calzature, Microtecnica, Industria Italiana Vernici e un folto gruppo di immobiliari operanti in Piemonte, Liguria e Lombardia. Siamo nel 1939. A maggio Germania e Italia firmano il Patto d’Acciaio. Il 3 settembre Francia e Inghilterra dichiarano guerra al Terzo Reich. Come nulla fosse successo, Agnelli in ottobre stipula con il governo francese un contratto per la fornitura di 2.200 autocarri, specificando che questa sarebbe stata la prima di una serie di consegne. Contemporaneamente continua a inviare motori di aviazione in Inghilterra e bombardieri in Persia, caccia in Ungheria e in Spagna, aerei e automezzi in Paraguay, Venezuela, Jugoslavia e Finlandia.
Nonostante l’Italia stesse per dichiarare guerra a fianco della Germania, nell’aprile 1940, il fiduciario della Banca Morgan, a nome di Agnelli, si recò a Londra per comunicare al governo inglese la disponibilità della Fiat a continuare a fornire aerei e motori d’aviazione. Allo stesso tempo Valletta faceva cadere sul governo di Roma, a pioggia, richieste di agevolazioni, esenzioni fiscali e contratti privilegiati. In considerazione del fatto che la Fiat era stata “fortemente danneggiata dai provvedimenti d’embargo degli Stati Uniti” Agnelli chiese di “vincolare il rilievo della SIAP [la struttura della Standard Oil in Italia] al proprio settore petrolifero”.
Le forniture militari richieste alla Fiat marciarono con ingiustificabili ritardi: il livello delle consegne previsto per il 1940 fu raggiunto solamente alla fine del 1942. Qualcuno cominciò a parlare di sabotaggio e alcuni gerarchi minacciarono il commissariamento.
Le crescenti pretese del presidente dell’industria piemontese e di tutti gli altri industriali, che peraltro stavano profittando di una crescente liquidità generata dagli ingenti guadagni “di guerra”, provocarono un irrigidimento da parte del governo. Mussolini, in un Consiglio di ministri del 1941, in uno scatto d’ira, minacciò: “Nessuno pensi che la tessera annonaria sarà abolita alla fine della guerra. Essa durerà finché esisterò. Perché così i vari Agnelli e Donegani mangeranno come il loro ultimo operaio”.
Ma, a far finire la cuccagna dei profitti, ci pensarono il precipitare degli eventi bellici e i bombardamenti su Torino della fine 1942. Trentasei bombe da 500 libbre ridussero gran parte della Mirafiori in macerie.
D’altronde i grandi industriali italiani – Agnelli, Donegani, Pirelli e Volpi – già nel novembre 1942 – ve ne è testimonianza nel diario di Ciano – avevano deciso di sganciarsi dal Regime fascista e organizzarsi per il “dopo” sotto altre bandiere. Agnelli e Valletta impegnarono tutti i propri sforzi per ricrearsi una “verginità” politica, collaborando col nascente Comitato di Liberazione e largheggiando in finanziamenti ai partigiani. Saranno loro stessi a documentare questa attività quando, a guerra finita, dovettero difendersi dall’accusa di collusione con il Regime fascista e collaborazionismo con i tedeschi.
Saranno loro stessi a documentare questa attività quando, a guerra finita, dovettero difendersi dall’accusa di collusione con il Regime fascista e collaborazionismo con i tedeschi.
Valletta agì secondo quella che lui stesso, presso i suoi collaboratori, definiva la “tattica del camaleonte”. Cercava di mostrarsi amico di tedeschi e fascisti repubblicani, ma contemporaneamente cercava contatti con i comandi anglo-americani ed elargiva finanziamenti e aiuti di ogni genere al Comitato di Liberazione e ai gruppi partigiani. Quando, dopo, si parlò di “doppio gioco” della Fiat, intervenne Giorgio Bocca specificando: “anche triplo e quadruplo gioco”.
D’altronde c’era chi se n’era accorto; Giuseppe Solaro, federale di Torino del PFR, riferendosi ai massimi dirigenti Fiat chiarì: “si sono messi apparentemente nelle mani germaniche, lavorando poi di abilità sotto sotto, per rendere la ‘protezione’ economico-militare un alibi alla concreta opera di sabotaggio e di ostruzionismo”. Giorgio Pini, che è considerato, tra i fascisti, uno dei più pacati e che nella sua ultraventennale carriera di redattore capo de il Popolo d’Italia, direttore del Resto del Carlino e nella RSI sottosegretario all’Interno – aveva espresso solo giudizi ispirati da grande equilibrio, dopo una missione in Piemonte, scrisse di aver trovato a Torino “una borghesia che ordisce la congiura antifascista nel Comitato di Liberazione con tendenza conservatrice e reazionaria [...] Tipico il caso dell’ing. Valletta e dei suoi collaboratori che si appoggiano alternativamente ai tedeschi e alle masse, naturalmente a loro danno”.
Durante il processo a Rodolfo Graziani, Valletta, ascoltato come testimone, confermò in maniera circostanziata ciò che avevano intuito i fascisti: “Abbiamo fatto in modo che il lavoro non fosse produttivo; e per non produrre abbiamo concertato degli attacchi aerei da parte dell’aviazione alleata [...] in modo che vi fosse la scusa di trasportare altrove il macchinario, di smontarlo e rimontarlo e quindi un lavoro che impegnava sempre tutto il personale, ma permetteva di non concludere nulla. E in tutto questo abbiamo avuto l’appoggio incondizionato dei partigiani, i quali si sono fatti in quattro, certe volte, per rendere sempre più difficili le operazioni di spostamento. [...] Qualche volta il materiale veniva sequestrato dai partigiani che poi ce lo restituivano”.
E non si trattò certo di una tattica improvvisata e circoscritta a situazioni contingenti e locali. Anzi, Agnelli aveva mandato il nipote Gianni al Sud, a mettersi a disposizione del governo Badoglio e collaborare nella costituzione dei primi reparti del Corpo italiano di Liberazione. Mentre Valletta si recava a Salò per dichiararsi “riconoscente” per la legge sulla socializzazione (1) e rassicurare Mussolini sulla disponibilità ad applicarla subito e ottenere, in cambio, la nomina di uno dei suoi uomini, l’ingegner Corrado Orazi, a direttore del Comitato per la motorizzazione della Repubblica, Agnelli dislocava nella Roma occupata due suoi dirigenti, il barone Schmidt di Friedberg e l’ingegner Giulio Foglia – che affiancarono il conte Giuseppe Perotti, già residente nella Capitale per curare i rapporti tra l’azienda torinese e i ministeri, e il marchese Giovanni Visconti Venosta, consigliere d’amministrazione della Fiat, rimasto appositamente a Roma – per mantenere i collegamenti con i comandi anglo-americani.
“Foglia – riferisce Castronovo – giunto a Roma il 10 settembre, era entrato in relazione con il generale Armellini, uomo di fiducia di Badoglio, assurto nel gennaio 1944 a comandante militare clandestino di Roma. [...] Dai primi di ottobre l’emissario di Agnelli aveva incominciato a intrattenere relazioni stabili con l’Office of Strategic Services”. Contemporaneamente Agnelli e il presidente dell’Unione industriali di Torino, Giancarlo Camerana, entravano in rapporto con il tenente colonnello Giuseppe Bertone, comandante del gruppo militare clandestino “B” e ufficiale di collegamento dell’VIII Armata britannica.
Tramite un funzionario di secondo piano della Fiat, Benedetto Rognetta, e il socialista Piero Passoni, Agnelli e Valletta fecero arrivare cospicue somme al movimento partigiano. Nel 1944, 30 milioni in unica tranche e 26 milioni in più versamenti. Successivamente, oltre 36 milioni furono fatti recapitare ai comandi della Resistenza tramite Annibale Vola, amministratore dell’IFI. Inoltre furono forniti gratuitamente – come testimoniò lo stesso Valletta – “mezzi di trasporto, carburanti e materiali a bande patriottiche per un importo valutato intorno ai 500 milioni”. Il presidente della Commissione economica del CLN di Torino, Guglielmone, dichiarò che durante la lotta clandestina “importantissimi aiuti in denaro e diverse decine di milioni furono versati con fondi personalmente forniti dal sen. Agnelli (la Fiat, sorvegliatissima, non poteva sborsare fondi) al CLN del Piemonte (versamenti che furono effettuati in modo continuativo, anche quando furono sospesi da altri finanziatori)”.
Nella concitazione della fine d’aprile del 1945 e delle settimane che seguirono – nella provincia di Torino si contarono circa 5.000 assassinii di fascisti o presunti tali – anche per le alte dirigenze Fiat ci furono momenti di grande tensione, ma tutti risolti velocemente e senza particolari danni. Giovanni Agnelli fu arrestato e portato in carcere alle Nuove, ma passò in cella una sola notte. La mattina successiva fu liberato “con tante scuse”.
L’Unità esce con un articolo di fuoco, “Pietà l’è morta”, a firma di Giorgio Amendola, ed è lo stesso dirigente comunista che in un comizio nella sala mensa di Mirafiori comunica la condanna a morte – poi smentita dai comandi CNL – di Vittorio Valletta. “A lu piuma ades? – lo prendiamo adesso?” urlano i partigiani presenti. Ma le protezioni di cui gode il dirigente Fiat sono tutte operative ed efficaci. Valletta è fatto riparare prima nella Prefettura di Torino, poi in una casa in collina, infine in una villa nel Monferrato presidiata dai militari inglesi. Quando i partigiani comunisti arrivano, viene esibito loro un documento che pone il ricercato sotto protezione delle Forze Armate inglesi “per benemerenze recate alla causa alleata”. Nel frattempo la Fiat viene affidata, temporaneamente, dai comandi partigiani a un Comitato composto da quattro personaggi – Aurelio Peccei, Arnoldo Fogagnolo, Gaudenzio Bono e Battista Santhià – tre dei quali fidatissimi uomini di Valletta, da lui stesso indicati a chi si stava occupando di insediare il nuovo organismo gestionale. Questi retroscena si conobbero solamente molto dopo, a seguito della pubblicazione dei rapporti dell’epoca dei servizi segreti americani.
Poi, le accuse a carico di Agnelli e Valletta di “aver partecipato alla vita politica del fascismo con notorie pubbliche manifestazioni di apologia degli atti di governo e di partito e avere notoriamente lucrato grandi incrementi patrimoniali con vantaggio economico ingentissimo” si sgonfiarono tutte col proscioglimento in istruttoria. La notizia raggiunse il settantanovenne senatore nella sua casa di Torino dove, il 16 dicembre 1945, morì. Al suo funerale, racconterà il nipote Gianni, “eravamo poche decine di persone”.
L’impero finanziario e industriale degli Agnelli fu allora preso in mano da Vittorio Valletta che lo diresse fino al 1966. Dopo la guerra gli affari erano ripresi come prima, con la disinvoltura di sempre: facili licenziamenti e pagamento “ridotto” delle fatture dei fornitori. Un “autoscontro” d’autorità che – come documentato da Mario Giovana – mandò in rovina centinaia di aziende nel torinese. Si riprese con la ricostruzione degli stabilimenti distrutti dai bombardamenti, con l’ottenimento di grandi commesse – dall’Italia e dall’estero –, con la produzione di nuovi modelli di autovetture di successo, con la rincorsa a tutti i contributi, i finanziamenti e gli incentivi possibili. Si cominciò coi prestiti previsti dal Piano Marshall, assorbiti dalla Fiat nella misura del 26% del totale assegnato all’Italia, provocando vive proteste da parte di tutti gli altri industriali. Gli immobilizzi necessari per mettere in produzione le prime forniture estere furono poi coperti dal fondo per il finanziamento dell’industria meccanica istituito nel 1947.
Nel 1950 la produzione di auto raggiunse la quota di 115.000 esemplari annui. Alla fine degli anni Cinquanta, con una struttura che dava lavoro a 65.000 operai, il fatturato della Fiat raggiungeva una cifra pari al 14% delle entrate complessive dello Stato.
I nuovi programmi di espansione imposero l’apertura di altri stabilimenti e da quel momento la Fiat cominciò a produrre anche all’estero. Francia, Spagna e Argentina furono le sedi delle nuove officine. Nel 1965 fu la volta dell’Unione Sovietica dove, a Togliattigrad, fu realizzata una vera e propria “città dell’automobile”.
L’anno successivo fu realizzato un ulteriore complesso alle porte di Torino – Rivalta – che provocò l’afflusso di altri 60.000 operai, quasi tutti del Sud Italia. Nel 1967 si ha l’assorbimento della OM e dell’Autobianchi e l’acquisto del 50% della Ferrari; nel 1969 è acquisita la Lancia.
È di questo periodo l’apertura di nuovi stabilimenti in Italia, di minori dimensioni rispetto a quelli torinesi, costruiti soprattutto in zone dove era più facile ottenere contributi ed esenzioni fiscali. La Fiat compare così, inaspettatamente, anche a Bari, Cassino, Lecce, Vasto, Sulmona e Termini Imerese.
Lo sviluppo della Fiat continua a procedere in corsia preferenziale sia per ciò che riguarda i contributi statali a fondo perduto, sia per i finanziamenti agevolati. Anche nei confronti della concorrenza è sempre operativa la longa manus dell’azienda torinese cui è spudoratamente consentito di bloccare quei progetti e quelle iniziative non compatibili coi propri interessi.
Qualche esempio. Nel 1954, nello stabilimento Alfa di Pomigliano – azienda IRI – è realizzato il prototipo di una vettura con cilindrata inferiore ai 500 cc. che anticipa in modo sorprendente sia la Mini Morris dell’inglese Leyland che la Bianchina dell’Autobianchi. Inaspettatamente il governo boccia il progetto, che prima finisce sulla scrivania del presidente del comitato dei ministri per il Mezzogiorno, il democristiano Pietro Campilli, poi – come riferirà Giuseppe Luraghi, direttore generale di Finmeccanica – su quella di Vittorio Valletta (!). Nel 1957 la Fiat lancia la Cinquecento e si impadronisce dell’ampia fetta di mercato adatta all’utilizzo di questo tipo di cilindrata.
Sempre negli anni Cinquanta Giorgio Valerio, titolare della SAIE, un’azienda milanese che rappresenta la General Motors, offrendo una grande struttura di vendita e di assistenza, affida all’ingegner Enrico Benzing – allievo del professor Mario Speluzzi del Politecnico, progettista dell’Isetta, una microvettura prodotta nel 1953 dalla ISO e nel 1955 dalla BMW – un progetto all’avanguardia che anticipa decenni di problematiche legate all’inquinamento e alle fonti energetiche: un veicolo ibrido, con motore a scoppio e motore elettrico. Già allora lo smog era d’attualità e il mercato che si offriva alla nuova macchina era enorme. Valerio si collega con la Edison – che si dimostra entusiasta – e mette in concorrenza General Motors e Volkswagen per la veloce realizzazione, nel Nord Italia, di una grande struttura di produzione. Alla Bridgestone giapponese è già ordinata una prima consistente fornitura di pneumatici.
Poi, improvvisamente e inspiegabilmente, l’Edison comincia a frenare, trova pretesti per contraddittori rinvii, fino a bloccare tutto. Si scusano parlando di “manovre ad alto livello”. Successivamente, il presidente dell’ENI Eugenio Cefis spiegò cos’era effettivamente avvenuto: “C’era stato il veto della Fiat”.
All’inizio degli anni Settanta fu varata un’iniziativa rivoluzionaria nel settore del trasporto merci. Si voleva eliminare gran parte del traffico su gomma dal Nord al Centro-sud, potenziando e ristrutturando quello su rotaia. Le merci provenienti dalle regioni settentrionali dovevano essere inserite in container – da 20 o 40 piedi, secondo le esigenze – e trasportate con appositi camion dal punto di carico al più vicino scalo ferroviario. Tutti i container convergevano, via rotaia, allo scalo di Pomezia e di lì smistati, caricati su altri camion e consegnati in tutto il Centro-sud. Il centro di Pomezia era stato adeguatamente strutturato: un enorme piazzale movimentazione con adeguate gru, trattori e personale specializzato nel traffico merci e nello spostamento degli speciali vagoni porta-container.
Le merci spedite la sera dal Nord, la mattina erano smistate a Pomezia e in giornata venivano consegnate nelle località del Centro-Sud; praticamente lo stesso tempo che occorreva con un trasporto effettuato tutto su gomma. I vantaggi erano grandi e molteplici: diminuzione dei costi, risparmio energetico con conseguente riduzione dell’inquinamento e, soprattutto, drastico ridimensionamento del traffico autostradale. Non più file negli snodi e nei passi appenninici, meno incidenti, più scorrevolezza. La categoria dei camionisti era ugualmente impiegata – per la distribuzione e la consegna dei container – ma con un lavoro meno massacrante e pericoloso. Però si sarebbero venduti meno camion e quelli in circolazione sarebbero durati più a lungo. Ancora una volta da Torino arrivò una forte opposizione; il centro container di Pomezia, già attrezzato e operativo, fu ridimensionato; le nostre autostrade continuarono ad essere piene di traffico e incidenti, l’Italia dei trasporti rimase stretta, lunga e complicata. Ma il paese di chi fabbrica e vende camion rimase un bengodi.
Quando, negli anni Trenta, dalla Fiat erano giunti al governo insistenti richieste per favorire l’aumento della produzione di camion, Mussolini aveva risposto: “La motorizzazione non può essere spinta oltre un certo limite sotto pena di comprometterne i vantaggi”. Ma quelli erano altri tempi.
Nel febbraio 1964 si verifica qualcosa in controtendenza. Il governo Moro, il primo con la partecipazione diretta dei socialisti, adotta misure anticongiunturali che frenano la corsa ai consumi e penalizzano i pagamenti rateali. La Fiat si sente danneggiata. Valletta è furibondo: “malgrado nostra specifica richiesta, non siamo stati sentiti prima dell’annuncio ufficiale dei provvedimenti. [...] Come possiamo essere governati da gente così? Come è possibile?”. E reagisce, come è sempre solita fare la Fiat in casi del genere, con la mannaia: riduce la settimana lavorativa da 48 a 44 ore. Commenterà Pietro Nenni: “un provvedimento provocatorio”.
Ma il governo Moro passò, mentre la Fiat e i suoi “buoni” rapporti con ministri e apparati dello Stato rimasero. Per trovare ancora un sussulto di dignità della politica nei confronti dell’azienda torinese, si dovrà attendere Bettino Craxi che, in più occasioni, denunciò il lavoro di logorio del potere pubblico espletato dalla Fiat attraverso le leve del condizionamento economico e il controllo della stampa: “uno stato nello Stato”, “una monarchia nella Repubblica”.
Ma Craxi, come Moro, passò in fretta e tutto tornò sotto controllo. Fece, poi, epoca il comportamento di Romano Prodi quando nel 1996, da capo del governo, prima affermò: “Non lucideremo le maniglie di casa Agnelli”, poi si precipitò a firmare il decreto sulla rottamazione delle auto.
di Mario Consoli
L’Avvocato, la Trilateral e il gruppo Bilderberg (PARTE V)
Nel 1966 comincia l’era dell’ “avvocato”, che durerà 37 anni; Enzo Biagi ne fu uno dei più riverenti incensatori
Nel 1978 c’è la ristrutturazione del gruppo, che da quell’anno opererà attraverso Fiat auto spa (raggruppando Fiat, Lancia, Autobianchi, Ferrari e Abarth), Fiat ferroviaria, Fiat Avio, Fiat trattori e Iveco (raggruppando tutta la produzione di veicoli industriali).
Nel 1986 Romano Prodi, presidente dell’IRI, praticamente regala l’Alfa Romeo alla Fiat. Erano in atto trattative molto avanzate con la Ford che, quanto meno, avrebbero potuto servire a far lievitare il prezzo. Ma Prodi non dà segni di voler approfittare di questa elementare regola commerciale e cede subito. A tifare per la Fiat erano stati in parecchi: dal segretario Dc Ciriaco De Mita al ministro delle Partecipazioni statali Clelio Darida, al capo dei comunisti torinesi Piero Fassino.
La CEE protesta: “si tratta di un aiuto di Stato surrettizio e, come tale, proibito dal Trattato di Roma”, un comportamento incompatibile con le regole di concorrenza della Comunità. Il futuro presidente del Consiglio si giustificò dichiarando che quella era l’unica soluzione per salvare l’occupazione dei 16.000 dipendenti dello stabilimento di Arese. Ma già l’anno successivo 6.000 di quegli operai furono posti in cassa integrazione e le ultime Alfa uscite da quella fabbrica sono del 2000. Per l’enorme area – due milioni di metri quadrati – sin qui occupata da quell’industria, si parla di un futuro impiego come “polo logistico”. Per ora c’è rimasto solo il Museo storico delle auto.
Nel 1966 finì l’era di Vittorio Valletta. Il successore di Giovanni Agnelli aveva raggiunto, lavorando, gli 84 anni. Il 30 aprile è lui stesso ad annunciare all’assemblea degli azionisti l’inizio della gestione di Gianni Agnelli: “Da oggi il dottor Agnelli non è più soltanto il nipote di suo nonno”. Per l’anziano dirigente rimane la poltrona di presidente onorario. A novembre il capo di Stato, Giuseppe Saragat, lo nomina senatore a vita. Il 10 agosto1967 a Marina di Pietrasanta in Versilia, mentre è in vacanza, è colpito da emorragia cerebrale e muore.
Comincia l’era dell’ “avvocato”, che durerà 37 anni.  Enzo Biagi ne fu uno dei più riverenti incensatori: “C’è sempre stata, a Torino, una famiglia che per gli italiani contava, e aveva un peso nelle decisioni importanti: si chiamava Savoia, adesso si chiama Agnelli”. Ma, nonostante l’agiografia redatta per questo personaggio abbia diffuso nella pubblica opinione l’immagine di un grande industriale e di un abile uomo d’affari, in questo periodo la Fiat – contrariamente a ciò che avvenne ai tempi di suo nonno e di Valletta – passò diversi momenti al limite della tenuta, sino a rasentare la possibilità – nel 1973 – di essere “irizzata”.
Enzo Biagi ne fu uno dei più riverenti incensatori: “C’è sempre stata, a Torino, una famiglia che per gli italiani contava, e aveva un peso nelle decisioni importanti: si chiamava Savoia, adesso si chiama Agnelli”. Ma, nonostante l’agiografia redatta per questo personaggio abbia diffuso nella pubblica opinione l’immagine di un grande industriale e di un abile uomo d’affari, in questo periodo la Fiat – contrariamente a ciò che avvenne ai tempi di suo nonno e di Valletta – passò diversi momenti al limite della tenuta, sino a rasentare la possibilità – nel 1973 – di essere “irizzata”.
Nel 1980, mentre l’Opel costruisce 29 vetture per addetto all’anno e la Toyota 43, la Fiat ne produce solo 11. Le vetture invendute sono più di 50.000, l’indebitamento ha superato la soglia dei 6.800 miliardi e rappresenta più del doppio del patrimonio netto del gruppo. Agnelli arriva a ricorrere per sette giorni alla cassa integrazione di 78.000 dipendenti, praticamente i due terzi degli effettivi della Fiat auto. La Fiat ne uscirà solo grazie ai soliti aiuti di Stato e rocambolesche coperture finanziarie. Tra l’altro venderà il 10% dell’azienda alla Lybian Bank, la banca della Libia di Muammar Gheddafi.
Dopo vent’anni, all’inizio del secondo millennio, la situazione si ripete: le vendite calano dell’11%, il gruppo ha una perdita di 9.000 miliardi e l’indebitamento ha raggiunto i 60.000 miliardi.
Negli anni Novanta la Fiat aveva ricevuto dallo Stato oltre 10.000 miliardi di lire, mentre i suoi versamenti tributari raggiungevano a malapena i 6.500 miliardi; un’operazione, per l’Italia, in netta perdita.  Inoltre, mentre gli azionisti in quello stesso periodo avevano versato – sotto forma di aumento del capitale – 4.000 miliardi, ne avevano prelevati, come dividendi, ben 5.700.
Inoltre, mentre gli azionisti in quello stesso periodo avevano versato – sotto forma di aumento del capitale – 4.000 miliardi, ne avevano prelevati, come dividendi, ben 5.700.
Gianni Agnelli non fu dunque in grado di dare un’impronta personale continuativa, sempre in espansione, nella gestione della Fiat. Nonostante fosse presentato come “ultimo Re d’Italia”, fu costretto ad avvalersi di numerose collaborazioni, talvolta in disaccordo tra di loro, che produssero risultati alterni. Sul piano finanziario fu determinante l’assistenza di Enrico Cuccia di Mediobanca e sulle più importanti poltrone della Fiat si sono avvicendati, oltre al fratello di Gianni – Umberto – ,Vittorio Chiusano, Gianluigi Gabetti, Cesare Romiti, Carlo De Benedetti, Vittorio Ghidella, Paolo Cantarella, Roberto Testore, Luca Cordero di Montezemolo, Giuseppe Morchio e Paolo Fresco.
L’ “avvocato” privilegiava, a quello di Villar Perosa, il soggiorno nella sua casa di New York. A chi lo chiamava “un americano imprestato a Torino piuttosto che un piemontese in prestito a Manhattan” rispondeva con un sorriso sornione. Adorava collezionare quadri di grande valore e lo faceva anche quando ciò rischiava di compromettere la sua immagine di capo della Fiat, come accadde nel 1972. Mentre i comunicati aziendali denunciavano una crisi al limite del tracollo, Agnelli acquista, per la sua personale galleria, un Rousseau, Les Tropiques, alla cifra di 600.000 dollari. La notizia apparsa sulla stampa negli Usa e in Italia ha un forte effetto negativo. L’Unità titola: “Agnelli è il solo metalmeccanico italiano che non abbia problemi di quattrini”. L’ “avvocato”, a questo punto, a malincuore, commissiona due riproduzioni fotografiche dell’opera, da appendere nei suoi uffici, e vende l’originale ai giapponesi.
Ma Gianni Agnelli si piccò di essere – e lo fu – uomo di potere; dietro la scrivania appese un grande quadro rappresentante una tigre, che gli era stato donato dal principe Bernardo d’Olanda, presidente della Trilateral Commission – una specie di governo-ombra degli uomini più potenti del mondo fondato nel 1973 da David Rockefeller e Zbigniew Brzezinski – della quale l’ “avvocato” fece parte fin dall’inizio. Agnelli partecipò anche al Gruppo Bilderberg, che si riunisce una volta all’anno per discutere – e decidere – sulle grandi questioni del mondo.
Durante i suoi frequenti soggiorni americani, gli amici di cui circondarsi, Gianni Agnelli li scelse soprattutto fra gli ebrei, particolarmente tra quelli molto influenti: l’ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, David Rockefeller, il finanziere André Meyer, l’editrice del Washington Post Katherine Meyer Graham. La sede della Fiat Usa fu affidata al giornalista Furio Colombo – considerato l’ambasciatore di Agnelli negli Stati Uniti – che, al suo rientro in Italia, andrà a dirigere l’Unità.
Un “ultimo Re d’Italia”, dunque, sempre meno italiano e sempre più uomo d’affari internazionale. Negli anni Novanta fece l’accordo con il gruppo francese PSA. Anche in questi ultimi mesi, in perfetta sintonia con quell’agire, dopo aver messo le mani sulla serba Zastava e sull’americana Chrysler, la Fiat ha iniziato in Italia a chiudere gli stabilimenti del Sud e diminuire i posti di lavoro. All’estero, mentre conferma la sua presenza produttiva in Polonia, Brasile, Argentina, Turchia e India, sta sviluppando progetti in Serbia, Russia e Cina.
L’internazionalizzazione della Fiat la si individua, oltre che nella dislocazione dei suoi stabilimenti e nella scelta dei mercati, anche nella storia della dinastia degli Agnelli.
Una dinastia movimentata e anche funestata da molte tragedie, sulle quali indagare è sempre risultato molto difficoltoso a causa dell’estrema riservatezza dimostrata dagli Agnelli per le vicende legate alla famiglia. Quando la Rai decise di realizzare – per la regia di Mauro Bolognini – uno sceneggiato in quattro puntate ispirato al libro di ricordi di Susanna, Vestivamo alla marinara, il fratello Gianni non esitò a comprare – senza badare a spese – i diritti della fiction per sospenderne le riprese e impedirne la trasmissione.
di Mario Consoli
La morte di Edoardo Agnelli e l’ascesa degli Elkann (PARTE VI)
Ombre e misteri nel “suicidio” dell’erede al trono di casa Fiat. A Teheran si parlò subito di “complotto sionista”
Le prime tragedie di famiglia colpiscono proprio il capostipite, il senatore Giovanni. Dopo la prematura morte della figlia Tina, che lasciò cinque orfani in tenera età, perse il figlio maschio destinato ad essere l’erede dell’impero di famiglia.
Siamo nel 1935; Edoardo era di ritorno da Forte dei Marmi dove era andato a trovare i figli in villeggiatura, a bordo di un idrovolante pilotato dal leggendario Arturo Ferrarin; ammarato a Genova, scese sull’ala e si mise in posa per i fotografi, ma un pattino del velivolo urtò contro un tronco; Edoardo perse l’equilibrio e cadde verso l’elica ancora in movimento che praticamente lo decapitò.
La giovane vedova, Virginia Bourbon del Monte, figlia del principe di San Faustino, è ricordata da tutti come bellissima e piena di vita. Non rassegnata al ruolo di perenni gramaglie cui la famiglia del marito avrebbe voluto costringerla, riprese presto a frequentare il “bel mondo”, si occupò dei suoi sette figli, ma non disdegnò occasioni di svago e divertimento. È nota una sua lunga relazione con il famoso giornalista Curzio Malaparte, che la presentava in qualità di sua “fidanzata”, come riferisce Giuseppe Prezzolini.
Gli scontri con il suocero si fecero sempre più violenti e frequenti.  Dopo aver rinunciato al controllo del comportamento della nuora, il senatore fece di tutto per sottrarle i figli. Voleva essere nominato tutore dei nipoti così come era riuscito a fare, avendo poca stima del genero, con i figli di Tina. Si arrivò a situazioni d’ogni tipo: dall’utilizzo della polizia per bloccare il treno sul quale Virginia viaggiava con i figli – riportando con la forza i bambini a Torino, dal nonno – alla richiesta della donna di intervenire in sua difesa fatta direttamente a Mussolini, che si occupò del caso e ottenne che i bambini rimanessero affidati alla madre. Ciò nonostante Agnelli riuscì a decidere sull’educazione del maschio primogenito, Gianni, che fu affidata a Franco Antonicelli, un intellettuale antifascista amico di Piero Gobetti e Norberto Bobbio. I litigi con la nuora finirono nel 1945 con la morte violenta della donna in un incidente automobilistico, mentre si recava da Roma a Forte dei Marmi.
Dopo aver rinunciato al controllo del comportamento della nuora, il senatore fece di tutto per sottrarle i figli. Voleva essere nominato tutore dei nipoti così come era riuscito a fare, avendo poca stima del genero, con i figli di Tina. Si arrivò a situazioni d’ogni tipo: dall’utilizzo della polizia per bloccare il treno sul quale Virginia viaggiava con i figli – riportando con la forza i bambini a Torino, dal nonno – alla richiesta della donna di intervenire in sua difesa fatta direttamente a Mussolini, che si occupò del caso e ottenne che i bambini rimanessero affidati alla madre. Ciò nonostante Agnelli riuscì a decidere sull’educazione del maschio primogenito, Gianni, che fu affidata a Franco Antonicelli, un intellettuale antifascista amico di Piero Gobetti e Norberto Bobbio. I litigi con la nuora finirono nel 1945 con la morte violenta della donna in un incidente automobilistico, mentre si recava da Roma a Forte dei Marmi.
Fu poi la volta della tragica fine di Giorgio – fratello di Gianni – a soli 36 anni. Uomo brillante e giudicato da molti di viva intelligenza, finì invischiato in storie di droghe ed esaurimenti. Secondo la versione ufficiale si sarebbe gettato dall’ultimo piano della clinica dove era ricoverato.
Gianni fa un matrimonio di alto rango: sposa Marella, la figlia di Filippo Caracciolo, principe di Castagneto, duca di Melito e Segretario generale del Consiglio d’Europa. Da questo matrimonio nascono due figli: Edoardo e Margherita.
Edoardo, personaggio schivo e riservato, si dedica a studi filosofici e orientali. Nel 1974 si converte all’Islam. Nel 1988 si viene a sapere che fa uso di eroina: a Roma è indagato e poi prosciolto perché viene riconosciuta la detenzione di droga per uso personale. Nell’ottobre del 1990 è, per gli stessi motivi, arrestato in Kenia, a Malindi; a toglierlo dai guai si precipitò sul posto suo cugino Giovannino. Tra i due intercorrevano ottimi rapporti ed Edoardo non aveva mai manifestato disappunto per il fatto che il figlio di suo zio Umberto fosse stato designato come futura guida della Fiat.
Ma, dopo il 1997, le cose cambiano: Giovannino – a soli 36 anni – muore per una rara forma di cancro, la questione della successione si riapre e l’ “avvocato” sembra prendere in considerazione la candidatura del nipote John Elkann, primogenito della figlia Margherita. Edoardo non è d’accordo: “Se il potere della nostra famiglia cadesse nelle mani sbagliate – afferma – sarebbe una cosa estremamente pericolosa per questa nazione”; si dichiara disponibile, alla morte del padre, a prendere le redini dell’impero di famiglia; comincia a delineare scelte strategiche ed economiche nuove.  Edoardo crede nelle energie alternative e ritiene maturi i tempi perché un’azienda come la Fiat si dedichi a immettere nel mercato autovetture non inquinanti e a bassi consumi. I rapporti col padre cominciano a guastarsi; si parla di discussioni e di malumori.
Edoardo crede nelle energie alternative e ritiene maturi i tempi perché un’azienda come la Fiat si dedichi a immettere nel mercato autovetture non inquinanti e a bassi consumi. I rapporti col padre cominciano a guastarsi; si parla di discussioni e di malumori.
Della ventilata successione al giovane John, Edoardo non vuole nemmeno parlare. Gli vengono presentati dei documenti che prevedono la rinuncia, sua e della sorella Margherita, a posti di comando all’interno delle aziende di famiglia in cambio di un’adeguata liquidazione in denaro e beni immobili. Edoardo si rifiuta di firmare e denuncia pubblicamente il “tentativo di estromissione radicale dalla Fiat”.
Alle 10 di mattina del 15 novembre 2000 il corpo del primogenito di Gianni Agnelli viene trovato sotto un cavalcavia dell’autostrada A6 Torino-Savona, in località Fossano. Lo chiamano “il ponte dei suicidi”; dal greto del sottostante torrente Stura l’altezza del cavalcavia fa paura: 80 metri.
Arriva sul posto la polizia e il procuratore di Moncalieri, Riccardo Bansone, che dichiarerà al giornalista del Corriere della Sera: “Di sicuro c’è che il signor Agnelli è finito qui sotto. Non ho le prove inoppugnabili per affermare che si tratti di suicidio. Il suicidio è una delle tre possibilità che stiamo vagliando. Le altre due sono malore e omicidio”.
Il padre, l’ “avvocato” Gianni, riesce a raggiungere il posto, per il riconoscimento, solo nel primo pomeriggio. Alle 15 la salma è trasportata all’obitorio del cimitero di Fossano. Alle 17 è già a Villar Perosa dove prontamente arriva il nullaosta per la sepoltura. Lo scrupolo dei magistrati manifestato la mattina si è dissolto: nessuna indagine, niente autopsia. Trovato il corpo a metà mattina, la sera è già nella tomba di famiglia. In questi ultimi dieci anni molti giornalisti hanno cercato di analizzare i dettagli del “suicidio” ed hanno tentato di riaprire un’indagine così frettolosamente archiviata.
Come mai non c’era – come accadeva abitualmente – né autista né scorta? Perché alcuni testimoni parlarono di un corpo “quasi intatto”? Perché, sotto i vestiti, aveva la giacca del pigiama? Come faceva, dopo un volo di 80 metri – e quindi dopo un impatto calcolato sui 150 km orari – ad avere ancora le scarpe ai piedi, le bretelle allacciate e al collo una collana di palline di legno intatta? Come mai aveva del terriccio nelle mani, mentre il greto su cui era stato trovato il cadavere era una pietraia? Che logica può avere il fatto che, prima di morire, Edoardo avesse telefonato al dentista per spostare l’appuntamento? Come mai un pastore di mucche, tal Luigi Asteggiano, ha testimoniato di aver visto il cadavere sotto il cavalcavia già alle ore otto, mentre il Telepass della Croma di Edoardo ha registrato il passaggio al casello autostradale alle 8.59?
Inoltre, lo psicologo-amico Alberto Pini, che lo seguiva da undici anni, dichiarò che mai aveva avuto l’impressione che in lui potessero prender corpo intenti suicidi. Il suo amico e consulente finanziario Marco Bava affermò: “La storia di Caino ed Abele si ripete… Edoardo è morto perché era contro i giochi di potere che prima ti blandiscono, poi ti escludono, infine ti eliminano!”. E ancora: “Non mi pare credibile il suicidio. Negli ultimi giorni della sua vita Edoardo stava occupandosi di tante cose, studiava, era pieno di attività. Fra l’altro si riproponeva di ristrutturare casa sua, avrebbe voluto iniziare subito i lavori e aveva fissato per questo un appuntamento preciso col sindaco di Torino. Strano, no? Volersi suicidare e al tempo stesso voler chiedere di sveltire una pratica burocratica per ristrutturare quanto prima la propria casa…”.
Il giornalista Giuseppe Puppo, nel febbraio 2009, ha pubblicato un libro, Ottanta metri di mistero, dove sviluppa meticolosamente i molti aspetti inquietanti della morte di Edoardo Agnelli; ad oggi nessuna risposta è giunta ai quesiti formulati da Puppo.
Il giornalista Giovanni Minoli ha recentemente riproposto il “giallo”, dedicandogli un’intera puntata della sua trasmissione televisiva La storia siamo noi (RaiDue, 23 settembre 2010). Per l’occasione Sette, il supplemento settimanale del Corriere della Sera, è uscito con in copertina la foto di Edoardo Agnelli e il titolo Omicidio o suicidio? A Teheran si è parlato apertamente di “complotto sionista” messo in atto per eliminare un ostacolo che si frapponeva alla presa del potere all’interno della Fiat da parte di elementi ebraici; Edoardo, nella capitale iraniana, è stato ricordato, e onorato, come “martire”.
Soffermiamoci ora sulla sorella Margherita, il cui figlio primogenito, dopo tante tragedie, si è saldamente insediato al comando dell’impero Agnelli.
Bella e ribelle, già a 17 anni esce di casa e va a Roma dove conosce il giovane Carlo Torlonia, col quale vive per due anni, finché lui non si fa sopraffare dalla droga, che arriva ad ucciderlo. Di lì a poco incontra Alain Elkann, giovanotto elegante e apparentemente timido. Ha le nazionalità francese e americana e lavora a Torino, all’IFI. Pochi mesi dopo chiede di sposarla. Lui è di padre e madre ebrei, lei cattolica, optano quindi per il matrimonio civile. La cerimonia si svolge a Villar Perosa; “celebra”, in qualità di sindaco del paese, il padre, l’ “avvocato” Gianni, sotto il ritratto del “senatore”, capostipite della famiglia.
Lui è di padre e madre ebrei, lei cattolica, optano quindi per il matrimonio civile. La cerimonia si svolge a Villar Perosa; “celebra”, in qualità di sindaco del paese, il padre, l’ “avvocato” Gianni, sotto il ritratto del “senatore”, capostipite della famiglia.
Gli sposi si trasferiscono a New York, dove Alain viene assunto nella casa editrice Bantam Books, una delle tante aziende sparse per il mondo con partecipazione Fiat. Alla nascita del primo figlio cominciano gli scontri tra Margherita e la famiglia del marito: “Io intendevo agnellizzare il mio bambino, mentre l’altra parte voleva a tutti i costi elkannizzarlo”. Il primo round, quello della scelta dei nomi, si concluse con un compromesso: il bambino si chiamerà John, Philip – in onore del nonno e del bisnonno di Margherita – e Jacob – in ossequio alla religione ebraica –. Ma in famiglia è sempre stato chiamato Yaakov – poi contratto nel diminutivo Jaki – tanto per chiarire quale dei tre nomi avesse maggior peso. Alain Elkann, nel suo recente libro “Nonna Carla”, dedicato alla famiglia e alla morte della madre, non indica mai il suo primogenito con il nome John; è Jaki, Giacobbe, e basta.
Tutti gli articoli sono presenti nel quotidiano Rinascita
CONTINUA
Al maggio del 1915 gli stabilimenti di Agnelli avevano già fornito alle Forze Armate più di 1.600 autoveicoli e stavano lavorando ai 18P, destinati al trasporto delle munizioni, alla produzione di mitragliatrici e di proiettili. Alla concorrenza erano andate le briciole: 298 autoveicoli erano stati ordinati all’Isotta-Fraschini, 195 alla Spa, 120 all’Itala, 110 alla Züst. Giovanni Agnelli era divenuto praticamente il consulente del governo per gli armamenti e i trasporti. Dante Ferraris, vice-presidente della Fiat, era stato nominato capo del Comitato regionale di mobilitazione industriale, incaricato della ripartizione delle forniture. Il figlio di Agnelli, Edoardo, era stato inviato a Udine come vice direttore del parco automobilistico militare, alle dipendenze di un capitano che, nella vita civile, dirigeva la concessionaria Fiat di Milano. Il giornalista Ugo Ojetti arrivò a scrivere: “Agnelli è quasi il padrone”.
A questo punto l’Amministratore delegato della Fiat allarga il tiro agli eserciti alleati. Con quello russo firma un accordo per la fornitura di 6.000 autocarri con i relativi pezzi di ricambio per un importo di 240 milioni. Altre forniture vengono inviate in Francia. Neanche la rivoluzione di Ottobre e l’uscita della Russia dalla guerra bloccano gli affari di Agnelli che riesce a farsi pagare dai Soviet – con l’intercessione del sindacalista Bruno Buozzi e del direttore dell’Avanti, Giacinto Menotti Serrati – le forniture già effettuate al comando zarista e vende a Francia e Inghilterra la produzione ancora non consegnata, con un aumento del 20% dei prezzi precedentemente concordati coi russi.
Strada facendo la Fiat continuava ad assorbire pezzi di una concorrenza sempre più in difficoltà. Nel dicembre 1917 sono assorbite, grazie a un consorzio di garanzia diretto dalla solita Comit, anche le Ferriere Piemontesi, le Officine Diatto e le Industrie Metallurgiche di Torino. Si tratta di acquisizioni fondamentali, perché tutte aziende produttrici di materie prime necessarie alla Fiat, come acciai speciali, materiale ferroviario ed energia elettrica.
A guerra finita il bottino poi si fa internazionale: Agnelli riesce addirittura ad ottenere dei rappresentanti nella delegazione economica italiana al tavolo della pace, a Versailles. È così che alla Fiat furono assegnati:
- il pacchetto di maggioranza dell’Alpine Montangesellschaft di Vienna, proprietaria delle miniere di ferro della Stiria e di numerose fonderie e imprese metalmeccaniche;
- la partecipazione – assieme alla Terni, l’Ilva e l’Ansaldo – alla Società Commerciale d’Oriente per lo sfruttamento dei giacimenti carboniferi di Eraclea nell’Anatolia turca;
- le partecipazioni agli stabilimenti siderurgici di Servola, a Trieste.
I tre anni della guerra erano stati sufficienti ad imprimere alla storia della Fiat un’impennata senza eguali. Da 4.000 a 40.000 dipendenti. Un capitale che, tra titoli e partecipazioni, da 7 milioni del 1915 nel 1918 era lievitato a quasi 100 milioni. Cifra più vicina ai numeri delle leggi finanziarie dello Stato che a quelli dei bilanci delle industrie private.
Peraltro la concentrazione delle forniture militari in una sola azienda – 92% degli autocarri e 80% dei motori di aviazione – avevano anche causato gravi contrattempi nell’andamento delle strategie di guerra. Essendo state disincentivate le altre industrie a un incremento delle potenzialità produttive, quando si fu alla vigilia dell’attacco di Vittorio Veneto e le esigenze di rimpiazzare le perdite di autocarri subite nel corso delle battaglie – in particolar modo nella ritirata di Caporetto – divenne impellente, la sola Fiat non fu in grado di rispondere con la tempistica richiesta, causando intoppi più che preoccupanti.
Il 25 settembre 1918 lo Stato Maggiore segnala il problema. Il 12 ottobre il generale Pietro Badoglio invia un messaggio al presidente del Consiglio – Vittorio Emanuele Orlando, il grande difensore di Agnelli e della Fiat – per denunciare l’impossibilità di effettuare il “completamento dei piani di operazione militare” per colpa della mancata attuazione del programma di produzione di automezzi concordato con la Fiat quattro mesi prima.
Nonostante ciò, lo Stato continuò a concentrare le proprie commesse, a favorire l’elefantiasi di quell’industria torinese e a rimpinzare le tasche di Giovanni Agnelli. Riferisce lo storico Valerio Castronovo: “Agnelli non aveva più bisogno di intermediari per trovare udienza presso Orlando o presso Nitti per la sistemazione dei contratti stipulati con l’amministrazione militare o per la distribuzione delle “spoglie di guerra”. La Fiat riuscì infatti ad assicurarsi ampie possibilità di lavoro per i mesi successivi la fine delle ostilità. Ancora nel 1919 il governo continuò ad acquistare numerosi autoveicoli per provvedere alle necessità di trasporti delle regioni annesse. Il ministero degli Esteri si preoccupò inoltre di sollecitare accordi specifici con la Romania, la Polonia e il Belgio al fine di agevolare il collocamento della produzione automobilistica. E per altri automezzi Fiat si studiò un programma di incremento dei servizi pubblici. Agnelli ottenne, infine, un trattamento favorevole anche nella liquidazione delle commesse in lavorazione. Con un decreto del 19 giugno 1919 venne concesso alla Fiat e alla consociata SIA un indennizzo di 40 milioni per “mancato ammortamento di impianti e di attrezzi e per svalutazioni di materie prime”. Non solo; l’amministrazione militare si assunse il carico del ritiro delle parti lavorate di materiale bellico esistenti presso le officine di corso Dante al prezzo di oltre 32 milioni e la successiva retrocessione alla Fiat di tali materiali al prezzo di 7 milioni. Venne concesso, inoltre, il rimborso delle tasse di registro già pagate su forniture complete o frazioni di forniture annullate, mentre altre clausole accordarono alla società torinese il rimborso integrale delle penalità su forniture di materiale d’aviazione. Circa 65 milioni erano stati così elargiti alla Fiat”.
Tanta dovizia di aiuti, e quindi di liquidità, contribuirono ad aumentare la sfera d’influenza di Agnelli in ampi settori della realtà industriale nazionale: Dalmine, Magneti Marelli, Società Elettricità Alta Italia, Società Forze Idrauliche del Moncenisio, Società Idroelettrica Piemonte, Rumianca, Unione Italiana Cementi, Rinascente, Società Assicuratrice Industriale. E, assieme al finanziere Riccardo Gualino, la Fiat si assicurò un posto nel Consiglio d’amministrazione del Credito Italiano. Negli anni del dopoguerra per la Fiat continuano i “buoni affari”. Giolitti, prima di dimettersi, inasprisce la stretta doganale per ciò che riguarda auto e cuscinetti a sfere; un’automobile straniera viene così a costare il doppio di una italiana. E Agnelli, nel gestire i propri interessi, come ha già fatto in passato e farà in futuro, manifesta una spregiudicatezza ai limiti della liceità: all’insaputa del governo, vende una società siderurgica austriaca ottenuta dall’Italia al tavolo della Conferenza di pace. Si aprono delicate questioni politico-diplomatiche e il ministro Ivanoe Bonomi, visibilmente irritato, definisce “deplorevole” il comportamento dell’industriale torinese. Durante i moti politici e sindacali che seguirono la fine della guerra e sfociarono nell’occupazione delle fabbriche, Agnelli, seguendo di volta in volta ciò che gli appariva la convenienza del momento e confidando in un risolutore intervento politico di Giolitti, si distinse in una serie di iniziative personalistiche e contraddittorie che andarono a provocare ora gli attacchi dei sindacati, ora quelli degli altri imprenditori. La goccia che fece traboccare il vaso fu la promessa, poi ovviamente rimangiata, fatta ai sindacati di trasformare la Fiat in una cooperativa, grazie alla quale ottenne lo sgombero dell’occupazione degli stabilimenti. Il presidente della Lega Industriale, ingegner Mazzini, bollò questa iniziativa come “atto più che di indisciplina, di vera aberrazione”. La situazione divenne così tesa che Agnelli arrivò a minacciare le dimissioni. L’unico imprenditore a schierarsi, in quel momento, dalla sua parte fu il massone Vittorio Valletta che, nominato prontamente Direttore amministrativo della Fiat, seguì da allora al 1966 le vicende dell’azienda torinese in ruoli dirigenziali. Superata l’enpasse del momento, Agnelli ripartì con la sua opera di industriale e di finanziere. Ma con qualche difficoltà in più. Al governo ora c’era Mussolini e non più i suoi benevoli referenti Giolitti, Orlando e Nitti..
http://it.paperblog.com/una-storia-italianala-fiat-213043/

Nessun commento:
Posta un commento